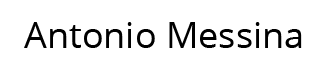(Credito immagine a questo link)
Vasileos
Un viaggiatore si perde su strade buie e sconosciute, quasi al confine fra Grecia ed Albania. Le luci di un paese lo rincuorano. La sosta imprevista sarà l’occasione per conoscere l’ospitalità e il segreto custodito dagli abitanti del villaggio.
Drammatico.
Lunghezza: 32.250 battute. Tempo di lettura: 25′.
Stato: pubblicato in “Quaderni Amerini”, n. 11, 2022, pp. 147-165. I diritti sono disponibili.
Riconoscimenti: finalista (quarto ex aequo) al Premio Amerino 2022.
Deposito legale: Patamu Registry.
La stessa strada di pochi rettilinei e curve innumerevoli, la stessa luce che s’incupiva fra le pareti di roccia, perfino la stessa pioggia. Oggi è sembrato tutto diverso, però. Hai un altro stato d’animo se sai quel che ti accade e il serbatoio è pieno. Vent’anni fa, invece, avevo quasi finito la benzina, perso la mia cartina chissà dove e i boschi infiniti fra Grecia ed Albania, al buio, non mi sembravano più così commoventi. I numeri del contachilometri sfilavano in processione senza che nulla intorno a me cambiasse e così avevo smesso di guardarli. La spia del carburante, con quel suo occhietto rosso, sembrava fosse lei a guardare me, fissa, malevola, beffarda. Ne aveva le ragioni. Qualche ora prima, anziché rimanere e aspettare prudentemente il giorno dopo, m’ero rimesso in viaggio e mi ero perso. Prima di ammetterlo avevo atteso troppo, quando la notte era ormai piena ed io lontano da ciò che conoscevo. Costretta troppo tempo in fondo al cuore, l’ansia spezzò i suoi lacci e crebbe rigogliosa.
Curve, alberi, monti, curve, alberi, monti … Il nero denso che li avvolgeva tutti. La strada che sembrava costruita e poi lasciata lì, come la casa di chi non è tornato per una decisione presa dal destino. E all’improvviso le luci, inaspettate, liberatorie. Luci che facevano sbocciare la speranza perché una sola sarebbe potuta essere qualsiasi cosa ma quelle che vedevo erano più di una, vicine l’una all’altra e dunque case, persone, sapere dov’ero. Forse da dormire, anche.
All’ennesima curva la strada si allargava a formare una minuscola piazzetta. Tre auto in sosta e un solo posto libero rimasto. L’abitato che distinguevo al buio non era più di quello che avevo immaginato. Mi resi conto subito che sperare in un albergo era sperare troppo. Del resto, ammisi a me stesso, solo il bisogno estremo di un sollievo aveva potuto farmi ipotizzare di trovarne in un agglomerato così piccolo, distante dalle rotte dei turisti.
Su un lato della piazzetta stava una piccola chiesa ortodossa; sul lato opposto, dei gradini portavano alla veranda coperta di una psistarià. La porta d’ingresso era illuminata da una lampada di potenza sproporzionata rispetto alla necessità apparente di dare luce alla veranda. Forse serviva anche un po’ come lampione. L’altalena del tergicristallo mi aiutò a calmarmi, i battiti del cuore tornarono a succedersi a intervalli più normali. Finalmente spensi il motore. Nel volgere di un istante la pioggia disegnò sul parabrezza rivoli ballerini. La giacca impermeabile era appallottolata dentro il bagagliaio. Per prenderla mi sarei bagnato comunque, così scesi dalla macchina e raggiunsi di corsa la veranda e finalmente la porta della psistarià. Il gesto semplice d’abbassare la maniglia bastò a farmi sentire ormai al sicuro.
L’interno del locale era modesto. Pareti bianche con appese poche foto in bianco e nero, tavoli di legno, tovaglie di carta, la luce delle lampadine di un giallo innaturale che falsificava il colore di ogni cosa. Su una mensa angolare, in fondo a destra, una radio diffondeva i suoni tesi d’una musica tradizionale. I clienti potevano sedersi a quattro tavoli in fila sulla destra e poi ad un quinto, più grande degli altri, posto di traverso a costeggiare la parete di fondo. Sulla sinistra, dove il locale in parte si allargava, un altro tavolo e un bancone offrivano allo sguardo i segni del tempo e qualche macchia. Dietro il bancone, un passaggio chiuso da strisce di plastica bianche e blu lasciava intuire una cucina, forse anche un’abitazione. Dei fili elettrici correvano sulle pareti coperti solo da uno spesso strato di vernice bianca. Una presa sporgeva dal muro in modo osceno.
Un’ora o poco più alla mezzanotte ma, mi sorpresi, ancora gente ai tavoli. Tre uomini conversavano davanti ai pochi resti della cena. In fondo al locale sedevano dei vecchi. Due di loro avevano scostato un po’ la sedia per poter tenere il bastone avanti a sé e godere, anche seduti, del suo appoggio. Il tavolo di fronte al bancone era occupato da due uomini d’età molto diversa: al più giovane davi una trentina d’anni, forse metà di quelli del più anziano. Sul loro tavolo c’erano soltanto due piccoli bicchieri da liquore colmi d’un liquido più trasparente del vetro che lo conteneva.
I tre davanti ai resti della cena furono gli unici a interrompere la conversazione per guardarmi; i vecchi si limitarono ad alzare lo sguardo e a voltarsi quel tanto che bastava per riconoscere in me uno sconosciuto. I due seduti al tavolo di fronte al bancone, invece, quando mi ero affacciato gocciolante mi avevano osservato con più attenzione degli altri. Gli domandai con un cenno di confermare che proprio a loro mi sarei dovuto rivolgere per avere del cibo e qualche informazione. Il più anziano si alzò e venne da me. Azzardai l’inglese ma ottennero di più le dita di una mano raccolte a mazzetto e portate due volte verso la bocca, gesto probabilmente universale per indicare fame. Una mano aperta mi indicò un posto libero al tavolo più vicino.
I dettagli della cena furono definiti con gli inciampi diventati abituali in quel mio viaggio. Era la seconda volta che trascorrevo le mie vacanze in Grecia ed altre volte vi sarei tornato ma, ancora oggi, di quella lingua conoscerò sì e no venti parole e di quelle venti, almeno la metà chiamano cibi: horiatiki è l’insalata greca, tzatziki la crema di yogurt con aglio e cetrioli, souvlaki gli spiedini di maiale e poi moussaka, pastitsio, psarosoupa … Nelle zone più interne di quell’Epiro che stavo attraversando, in una psistarià si può mangiare soprattutto carne. Poche parole e qualche cenno del capo a dire sì o no generarono la promessa di tzatziki, patate fritte e vino per accompagnare uno di quei salsicciotti che vanno sotto il nome di loukanika. Tono e gesti del mio interlocutore mi fecero capire che quasi si scusava per il fatto che a quell’ora non avrebbe potuto offrirmi molto altro. Lo rassicurai come meglio potevo: per quanto mi riguardava, quella cena era un regalo del destino.