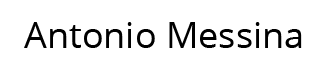Un anno a Monsummano
Genere: Umoristico
Lunghezza: 269.496 caratteri (tempo di lettura stimato: 3h 20′)
Stato: Inedito
Deposito legale: Patamu Registry
Un maschio trentenne e viziato, all’improvviso deve mettere su casa a Monsummano, cittadina toscana con un nome che attira storpiature come il miele fa con le formiche. Diventare adulto, però, non è una cosa facile, specialmente quando velleità da massaia, ansie domestiche e disavventure varie devono fare spazio al tentativo di farsi notare da Cristina, che lavora alle terme e di cui ci si è innamorati.
Con un esplicito piglio alla Jerome, il romanzo racconta di vicende minute e quotidiane che scandiscono il confronto con la vita “vera” fatta, anche, di problemi pratici per i quali ci si rivela inadeguati, di scontri con la burocrazia dai quali si esce vittoriosi soltanto per caso e del confronto reale con la persona che ti sta facendo sognare. Uscirne vivo con un minimo di equilibrio, forse, è già un gran risultato.
Prima di tutto bisogna che vi racconti della Tilde. Anziana, piccola, un po’ curva, l’aspetto bonario… A me, bambino negli anni Sessanta, quando la vidi per la prima volta ricordò la vecchina sorridente che ancora appare su certe scatole di cacao in polvere. Il nome un po’ curioso era diminutivo di Clotilde e di una persona che si chiamava in tal modo, se devo dirla tutta, mi fu sempre difficile anche soltanto immaginare che un tempo doveva pur essere stata giovane. Io la conobbi nel maggio del 1984 a Pistoia, in Toscana, dove i casi della vita mi avevano condotto circa un anno prima in sistemazioni sempre provvisorie e cambiate mediamente ogni due mesi fino a che, appunto, non incontrai la Tilde. Lei una brava donna, la stanza che affittava assai decorosa, il prezzo più che onesto, i vicini cordiali, la zona molto tranquilla e un solo inconveniente: la mia nuova padrona di casa aveva settantanove anni finiti, età in cui può accadere di morire o, riconsiderando la propria situazione, di preferire che in casa ci sia una badante anziché un giovane studente-lavoratore. Due ipotesi diverse, specialmente dal punto di vista della Tilde, ma che entrambe mi avrebbero di nuovo costretto a traslocare.
Perdonate la civetteria e lasciatemi affermare che i risultati del mio metodo furono lusinghieri e ci vollero ben dieci anni prima che la Tilde, una mattina, mostrasse il primo segno dell’invecchiamento. Fu quando mi accennò che fosse meglio, fatta colazione, che almeno io mi lavassi il cucchiaino. A quasi novant’anni, mi disse sospirando, non si sentiva più così gagliarda come quando ci eravamo incontrati. Il che forse era vero ma io sapevo: il medico pietoso fa la piaga puzzolente. Cedere anche solo su quel punto avrebbe spinto senza rimedio la Tilde sulla china pericolosa che conduceva all’inerzia, alla debolezza fisica e, con inarrestabile progressione, a quella mentale. Non potendo permettere che tali sciagure pesassero sulla mia coscienza, già rosa dal rimorso di non lasciarle mescolare miele e caffellatte, mi vidi costretto a negarle anche il piccolo aiuto che chiedeva. Per convincerla delle mie ragioni ci volle un mese intero, poi la Tilde si rassegnò ed un bel giorno, ritornato a casa dal lavoro, trovai l’acquaio finalmente sgombro dai trenta cucchiaini che vi si erano accumulati e che quella testolina testarda s’era ostinata a non voler lavare.
Non dirò che sia stato tutto merito della mia fermezza, fatto sta che la Tilde tirò avanti egregiamente un altro annetto prima che il tempo prevalesse anche su lei. Accadde nell’aprile del 1995: un malore; l’intervento del medico; i giorni sospesi fra le speranze di ripresa e i timori di un tracollo; infine il superamento della crisi che, tuttavia, modificò lo stesso il corso della mia vita perché la Tilde, pur di nuovo in gamba, decise di destinare la mia stanza alla persona che l’avrebbe assistita da quel giorno in poi.
Come dovetti amaramente constatare, i dieci anni trascorsi per la Tilde erano stati dieci anche per me che ne avevo compiuti 35 e, dovevo ammettere, come giovane studente-lavoratore non ero più credibile. Pensarci mille volte servì soltanto a dirmi che non avevo scampo: era giunto il momento di diventare grande.
Quando arriva, quel momento cambia profondamente la nostra vita. I sogni, le ingenue ambizioni, le ore spensierate e quelle malinconiche della gioventù cedono il passo al realismo e al buon senso tipici degli adulti. La vita smette i panni giocondi delle domeniche trascorse giocando a calcio; delle riunioni appassionate; delle battaglie navali sottobanco durante l’ora di religione; dei sabati sera in discoteca o al cinema; delle pizze con gli amici tirando a far tardi; delle canzoni cantate a squarciagola nella notte mentre si torna a casa sull’automobile del primo patentato del gruppo, che se è estate, e l’auto è scoperta, lo si ricorderà per sempre. Da quel momento in poi, tristemente, fanno la loro comparsa bollette e ferri da stiro; panni da stendere e carrelli da spingere; riunioni condominiali e deleghe anche al gatto del vicino pur di non andarci. E ai nostri amici (vecchi o nuovi che siano) sempre più spesso si dovrà dire che chi non muore si rivede e scusa se non ti ho chiamato e davvero non c’è stato il tempo e guarda ho avuto un periodo e appena c’è un attimo bisogna vedersi e ora devo lasciarti ma ti chiamo quanto prima e questa domenica non posso ma appena posso passo. Ma il vero guaio, da quel momento in poi, è che dobbiamo cavarcela da soli. In parole povere (le uniche che mi posso permettere, del resto) la vita ci pone nudi e disarmati di fronte alla società post-industriale e alle sue insidie. E se a volte si tratta di un processo lungo e travagliato altre volte accade così, da un giorno all’altro, senza che nessuno si sia preso la briga di avvisarci. Ci capita qualcosa, magari un fatterello dall’apparenza insignificante e dopo qualche anno, ripensandoci, ci accorgiamo che quel fatterello banale, giunto nella notte come la befana e di soppiatto come un malvivente … Ebbene sì: altro non era che il passaggio dalla giovinezza all’età matura. E mica la metafora, proprio il passaggio vero!
Fatto sta che all’età veneranda di 35 anni mi dovetti mettere in moto per cercare casa. Siccome non l’avevo, la moto la presi in prestito dal mio amico Leonetto e cominciai il calvario fra “libero buono stato”, “trivano terzo piano”, “terrazza verandata”, “rudere da ristrutturare con annessi 5.000 metri quadri a uliveto” o la “porzione colonica” che, a giudicare dal prezzo, a chiederla al ristorante anziché una bistecca ti portano una mandria. Poi c’erano anche i mansardati; i terratetto liberi su tre lati; i casolari da cui si potevano ricavare due unità con ingresso indipendente; gli ottimamente rifiniti; i bilocali posti al piano terra e gli appartamenti in costruzione consegna a dieci mesi. Poi ancora il “piccolo monolocale soppalcato completo di servizio”, l’“ottimo confortato disposto su tre livelli” e il bugiardo “locato con sfratto esecutivo confortato tranquillo”. Per quanto confortato, come faceva a essere tranquillo con lo sfratto esecutivo?
…
Nota editoriale
“Un anno a Monsummano” è un romanzo con delle radici. In una prima stesura e con il diverso titolo di “Un anno a Mussulmano” circolò nel 1996 fra amici e conoscenti. Una seconda stesura fu pubblicata nel 2000 dall’editore Transeuropa. Nel 2023, tagliando molto e anche “cannibalizzando” altri miei testi, ha preso forma quella che si può conteggiare come ottava stesura del testo del 1996 ma anche come la prima di un’opera significativamente nuova e meritevole, perciò, di un differente titolo.